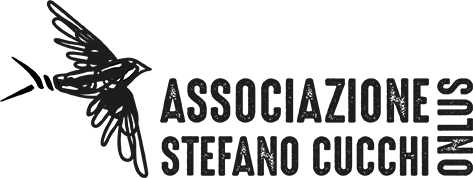Abderrahman Sahli e quello strano “trattamento” che gli è costato la vita
 Il 2 giugno 2011 a Montagnana moriva di Abderrahman Salhi.
Il 2 giugno 2011 a Montagnana moriva di Abderrahman Salhi.
Era una prassi quel “trattamento” che prevedeva l’immersione nelle gelide acque del fiume Frassine. Un “trattamento” applicato in violazione di qualsiasi garanzia giuridica e sempre nei confronti di immigrati senza fissa dimora, persone considerate cittadini di “serie B” contro i quali tutto, o quasi, è consentito. Almeno sette i casi accertati di cui sono stati protagonisti, loro malgrado, tre stranieri, tutti nordafricani. Prima o poi qualcosa poteva andare storto. Così è stato: ci è scappato il morto.
E se anche l’esatta dinamica dell’”incidente” che ha portato al decesso il 24enne marocchino Abderrahman Salhi non verrà mai chiarita, resta il fatto che quella pratica di “memoria cilena” fu abusata per oltre un anno da due rappresentanti dell’Arma dei carabinieri di Montagnana nel silenzio generale di chi sapeva e ha scelto di stare zitto. Fu il ritrovamento del corpo senza vita di Salhi a far scattare l’indagine da parte del procuratore aggiunto di Padova, Matteo Stuccilli, con la collaborazione del pubblico ministero Roberto D’Angelo. E a provocare la scoperta di quanto messo in pratica da alcuni sottufficiali in servizio nella caserma di Montagnana. Nei giorni scorsi l’inchiesta è stata conclusa e la procura si prepara a sollecitare il processo per quattro carabinieri con una diversa declinazione delle singole responsabilità penali: il maresciallo capo Claudio Segata, 44 anni originario di Bolzano, e il carabiniere Giovanni Viola, 31 nato ad Avola (Siracusa), sono accusati di sequestro di persona e violenza privata continuati (con l’aggravante di aver commesso i fatti nella veste di pubblici ufficiali con abuso dei poteri e in violazione dei doveri relativi a una funzione pubblica) per sette episodi fra cui quello mortale; mentre l’appuntato scelto Daniele Berton, 44 anni originario di Legnago, con l’appuntato scelto Angelo Canazza, 42enne nativo di Monselice, sono chiamati a rispondere di aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati commessi dai colleghi, nonostante fossero agenti di polizia giudiziaria ai quali incombeva l’obbligo del rapporto. I primi due sono difesi dall’avvocato Stefano Fratucello, gli ultimi dal collega Giuseppe Pavan.
È una brutta storia sulla quale la magistratura padovana ha voluto fare chiarezza fin dalla mattinata del 23 maggio dell’anno scorso quando un contadino di Borgo Frassine, alle porte di Montagnana, dà l’allarme notando un cadavere nel corso d’acqua. Si tratta di Abderrahman Salhi, un ragazzo che conoscevano in tanti. Spesso si ubriacava, qualche volta dava fastidio. Eppure non era un criminale, soltanto uno sbandato. Otto giorni prima, il 15 maggio, era stato notato alla Festa del prosciutto perché importunava dei passanti. Qualcuno aveva raccontato di averlo visto salire a bordo di una gazzella dei carabinieri, poi più nulla. L’autopsia, eseguita dal professor Massimo Montisci, accerta che il corpo, rimasto in acqua almeno una settimana, presentava segni nella parte frontale compatibili con una caduta. A tappeto vengono interrogate decine di persone.
Il quadro è allarmante: si scopre che fin dall’estate 2010 “il trattamento in acqua” viene messo a punto dai due carabinieri per ben due volte nei confronti di un extracomunitario noto come “Monaco” e altrettante nei confronti di un connazionale, “Fragolino”. Nel maggio 2011 “Fragolino” è di nuovo costretto a immergersi nel Frassine. Ad aprile tocca a Salhi che, il 15 maggio, è di nuovo obbligato a “rinfrescarsi”. Non si sa che cosa sia davvero accaduto quel giorno: forse i due militari si allontanano mentre Salhi è ancora in acqua. Ubriaco fradicio e senza forze, non risalirà più: muore per annegamento.
In un articolo del giugno 2011 apparso sul “Corriere del Veneto” Roberta Polese raccoglie diverse testimonianze di quello strano “trattamento”:
«Altro che bagno forzato per riprenderci dalla sbornia, i carabinieri ci buttano giù dal ponte e noi ci dobbiamo arrangiare». Abele Abdelilah è nato a Marrakesh 45 anni fa, da 20 vive a Montagnana, dove ha anche un figlio. Non ha un lavoro perchè invalido, e sì, ha problemi di alcol. Vicino a lui, nella piazzetta di San Francesco, dentro le mura, si riunisce un gruppetto di stranieri. Il fare è sospetto, un misto di paura e di rabbia. Ma il più infuriato di tutti è Rahali El Hassane, 46 anni, carta di idantità italiana e residenza in via Mercato Giotto 5, a Montagnana. «Quattro volte mi hanno buttato sotto – dice in un italiano strascicato – mi sono salvato, e l’ho detto anche agli investigatori». Rahali, in arte «fragolino» (nota «passione» per il vino) sarà probabilmente il teste chiave della vicenda che ruota attorno ai quattro carabinieri di Montagnana indagati per la morte del 25enne Abderrahman Sahli, trovato cadavere sulle rive del Frassine il 24 maggio. Mercoledì due poliziotti sono andati a prendere Rahali e lo hanno portato in procura. Gli investigatori gli hanno mostrato le foto dei quattro militari sospettati, e lui li ha riconosciuti tutti. E ha raccontato la sua verità.
Ma ci sono altre testimonianze. Parla ancora Abele. «Ad Abderraham è successo quello che è capitato a me due volte: i carabinieri ci trovano ubriachi, ci fanno salire in macchina ammanettati, e senza passare dalla caserma ci portano su quel ponte, ci insultano, ci tolgono le manette e ci buttano giù con un calcio, noi ci salviamo perchè riusciamo ad arrampicarci sulle rive, altro che bagno». E poi c’è Jawad Lakhuil, ieri era il suo 31esimo compleanno, che mostra le ferite sul corpo. Dice che sono stati quei tuffi sul Frassine a provocargliele. Jawed viveva con la giovane vittima in una cascina diroccata vicino alle piscine. Un tugurio avvolto da erbacce e steppaglia, con un allacciamento abusivo alla luce, senza alcun servizio. Il 31enne è stato lì con la vittima fino al 15 maggio. Da allora se ne sta da solo.
Ma ad avere il polso di quanto accade a Montagnana sembra essere Abele, che conosce inglese francese e italiano alla perfezione, che tiene buoni i compagni infastiditi anche dai cronisti. Abele capisce che c’è voglia di capire, di sentire anche la loro versione. Parla, racconta, si commuove. E lo fa in una Montagnana svuotata: è ora di pranzo, tutti sono a casa. Fa caldo, ci sono solo due tecnici che provano l’audio del concerto che si è tenuto in piazza ieri sera. «Ho fatto il soldato ho combattuto la “desert storm” nel ’91 in Iraq, so cosa vuol dire portare una divisa, sono uscito dai caschi blu dell’Onu con il grado di maggiore e un braccio distrutto, sono arrivato qui e non ho un lavoro. Bevo, sì, perchè la mia vita fa schifo ma non faccio del male a nessuno». Abele, Rhali e Jawad non hanno idea dell’eco che il caso del loro connazionale morto sta provocando in tutta la provincia e oltre.
«Qua funziona così: ti caricano in macchina, e ti buttano giù dal fiume. Mai vista una caserma, non ci denunciano nemmeno. E noi che dobbiamo fare?». La risposta sta nel silenzio, e in altro alcol. Ma con la morte di Abderrahaman si fa sempre più fragile il confine tra rassegnazione e rabbia esplosiva. Ad Abele non par vero che qualcuno gli chieda di mostrargli dov’è il ponte. E ti fa fare anche la stessa strada che farebbero i carabinieri quando di sera li prelevano dalle piazze in auto. Lì gli argini sono talmente ripidi che per risalire ci vogliono ore. «Soprattutto con una buona dose di alcol ancora addosso» dicono i due marocchini. Da quanto andrebbero avanti queste «punizioni »? «Da quando è arrivato un maresciallo con i capelli bianchi, prima non erano così ». Perchè non andarsene, allora? «Qui ho un figlio» risponde Abel. Intanto in fianco a lui «fragolino» si versa altro vino dal cartone. E quando gli si chiede perchè tutto quell’alcol gli vengono gli occhi lucidi: «Voglio morire», risponde.